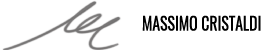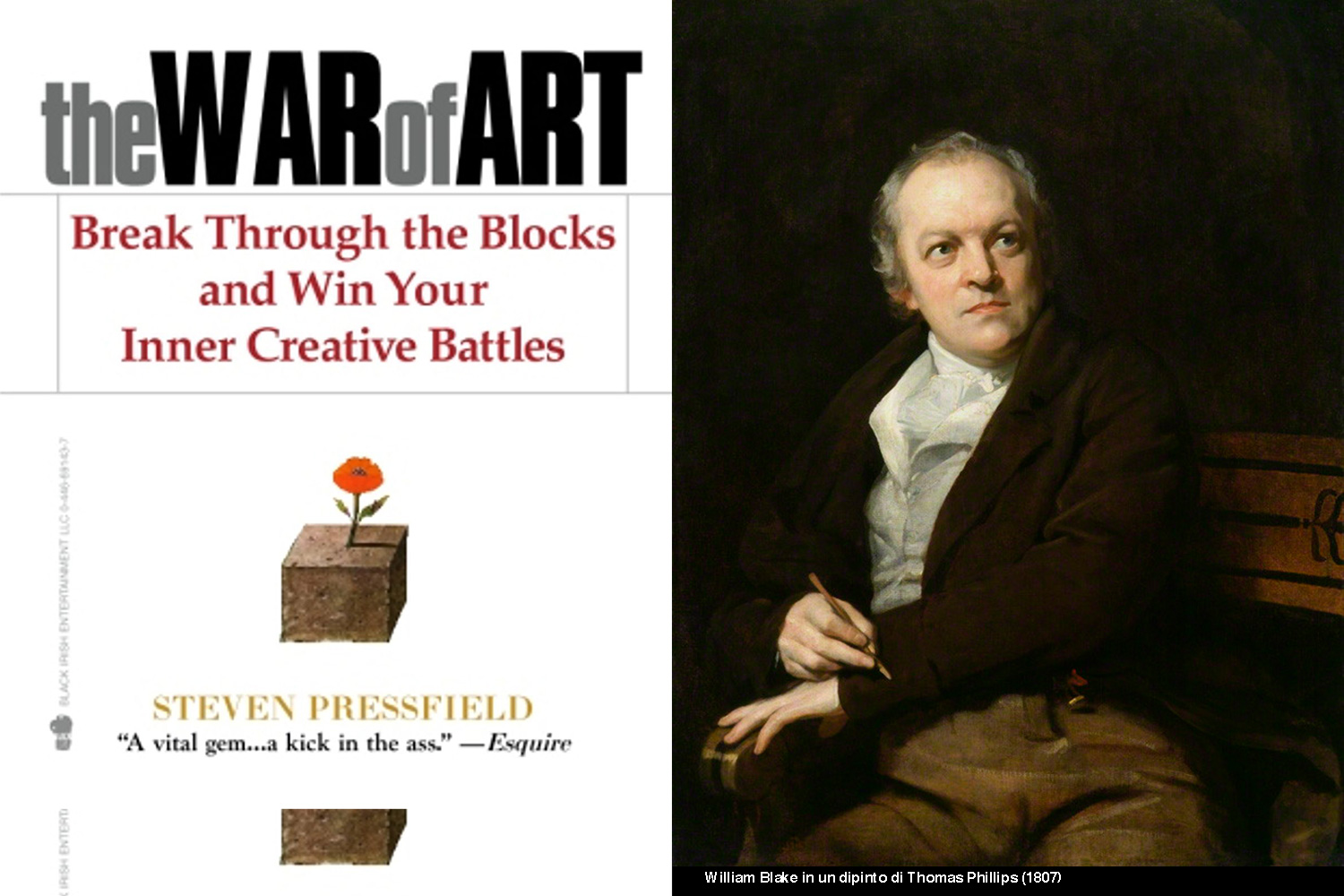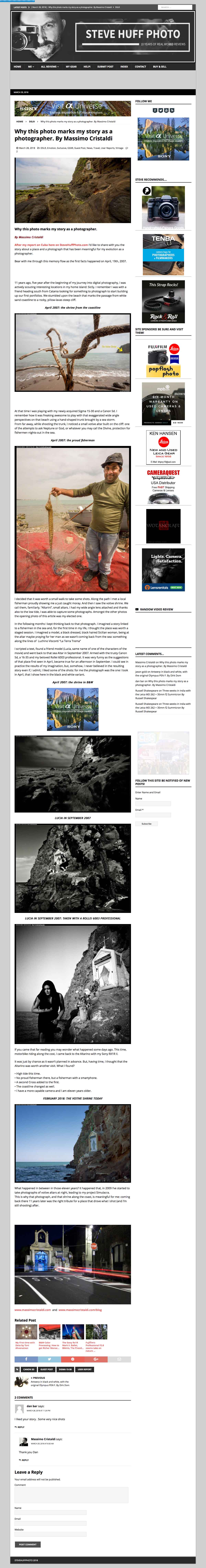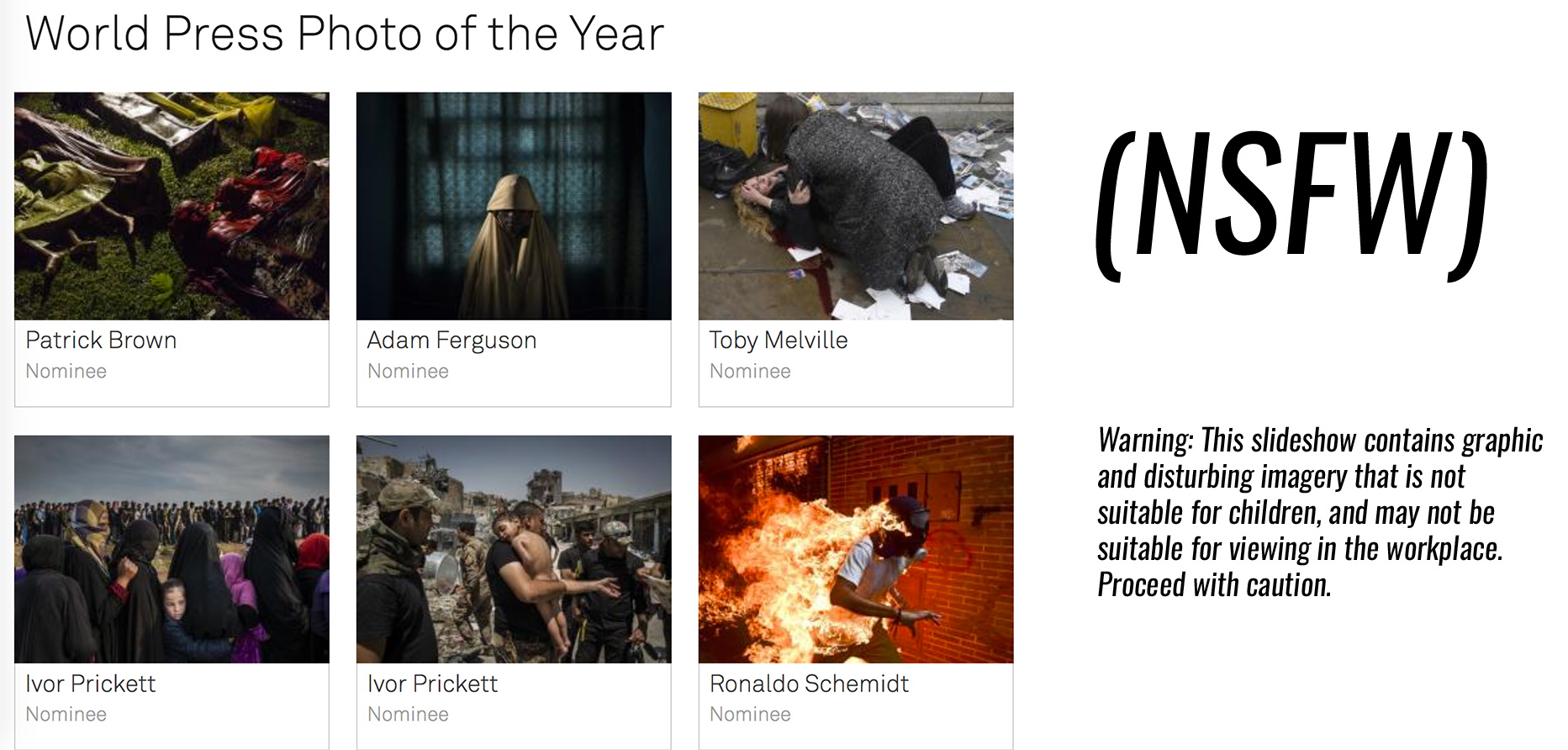Spectrum è una nuova iniziativa editoriale partorita dalla vulcanica fucina di Enzo Grabriele Leanza che, con passione e determinazione, ha messo su quello che lui definisce “bookzine”, ma che, anche per la qualità editoriale del progetto, si annuncia come una collana di libri fotografici:
L’idea di dare vita a Spectrum, un “bookzine” di cultura fotografica, nasce dall’esigenza forte di
trovare un punto di convergenza tra le diverse anime della fotografia, permettendo loro di dialogare
in una forma stabile e duratura. L’incontro e il confronto che ricerchiamo verranno messi in campo,
di volta in volta, utilizzando l’intervista come strumento principale d’indagine, in maniera tale da
dare parola direttamente ai protagonisti dei vari campi della fotografia. Insieme alle interviste ai
principali attori della scena fotografica, vi proporremo anche una parte “saggistica”. Quest’ultima
sarà pensata in modalità soft, con testi brevi e linguaggio accessibile anche a chi non frequenta per
mestiere studi più strutturati. Il nome scelto per questo bookzine mette insieme le anime che da
due secoli interagiscono costantemente ogni qualvolta si parli di fotografia: quella “scientifica” e
quella “umanistica”. Spectrum quindi, nella prima accezione, come spettro del visibile, quella parte
della “luce” che ci permette di vedere il mondo e che al tempo stesso ci consente di fotografarlo, ma
anche Spectrum come la pratica di cui parla Roland Barthes ne La camera chiara in cui tra
l’Operator (chi fa la fotografia) e lo Spectator (chi la “osserva”) si pone appunto lo Spectrum (ciò che
viene fotografo, l’oggetto che “subisce” l’azione fotografica).
Il primo numero della rivista contiene una lunga intervista che spazia attraverso tutti i miei lavori. L’intervista è disponibile per il download in PDF da questo link e, di seguito, la riporto in modalità testuale.
SPECTRUM: Ciao Massimo, pur svolgendo un’altra professione nella vita, da più di un decennio sei molto attivo nel campo della fotografia, come ti sei avvicinato a questa “disciplina”?
Ho iniziato da bambino. A circa dodici anni mio padre mi spiegò per bene i concetti di ASA, tempo e diaframma con la sua FED4 sovietica che ancora, sporadicamente, utilizzo. Lui era un appassionato fotografo, ed era una persona molto coinvolgente per natura e temperamento. Poi, negli anni Novanta, una prima reflex tutta mia, una collezione di obbiettivi e via dicendo. La vita mi ha portato verso la tecnologia e la scienza ma i viaggi e le motociclette sono sempre stati una grande passione. La fotografia è stata quindi il mezzo principale per raccontare la mia vita, i miei viaggi e, successivamente, per vedere realizzate le immagini della mia mente.
SPECTRUM: Il tuo lavoro procede come strumento d’indagine di quella che tu hai definito la “metafora dei confini”. Cos’è un confine per te? E in quanti modi questo concetto può essere declinato in fotografia?
Il confine è un concetto molto importante per me. Sono tantissimi i confini che ogni giorno attraversiamo, tanto quelli fisici, veri, come quelli tra le nazioni che quelli metaforici, come i confini tra terra acqua e cielo. O tra presente e passato. In questo senso la fotografia è per me un “confine fisico” di tipo temporale: con una foto marco un confine tra quello che ho ripreso un istante prima e quello che succederà un istante dopo. Il frame fotografico è confinato anch’esso: decido cosa escludere da quello che vedo. E se rappresento confini come soggetto delle mie immagini ecco che la metafora dei confini si compie nella sua completezza.
SPECTRUM: Il tuo modus operandi è caratterizzato dalla realizzazione di “lunghe” serie; progetti che insegui per anni e che realizzi con grande padronanza del linguaggio fotografico. Da quali esigenze nasce un tuo progetto?
La prima esigenza è personale. Mi attrae un qualcosa e decido di raccontarlo. E per farlo ci vuole del tempo. Ci vuole costanza e determinazione. Mi interessa la fotografia come documento, quindi ho sempre provato a raccontare storie che potessero diventare “documento” e “traccia”.
SPECTRUM: Alcuni di questi progetti li consideri conclusi, altri vengono dichiarati ancora “on going”. Come e quando si può mettere il punto definitivo a una serie fotografica?
Bellissima domanda. A volte perché trovo l’indagine “conclusa”, perché ho fotografie sufficienti a rispondere allo statement. A volte perché mi “disamoro” al soggetto. Ad esempio in Simulacra: ho lavorato tantissimo per circa un anno. E ho raccolto tante immagini. E oggi, anche se ogni tanto scatto ancora questi soggetti, non saprei come continuare, e forse non mi interessa neanche provare a farlo. Quelli “ongoing” sono più complessi. Rispondono forse di più a un mio modo di fotografare quindi chiuderli è più difficile, più “doloroso”.
SPECTRUM: Una serie ancora “aperta” è quella intitolata Suspended, lavoro in cui, riallacciandoti alla migliore tradizione internazionale del paesaggio fotografico, mostri luoghi che sembrano essere fuori dal tempo. Che ruolo hanno il “luogo” e il “tempo” nella tua fotografia?
Suspended è uno dei miei lavori per l’appunto aperti. ?à un mio modo di vedere la Sicilia che trovo sostanzialmente immutato da circa quindici anni. I luoghi, nella fattispecie, sono a me familiari: ci sono nato e me li porto dentro. Anche se mi piace molto scattare in viaggio è pur vero che è forse più appagante fotografare “a casa propria”. Hai più tempo per riflettere e per assorbire quanto vedi. Ecco, implicitamente ti ho risposto: luoghi, tempi e confini.
SPECTRUM: La notte è un elemento comune ad alcune tue serie fotografiche, come Simulacra, Touch Ground e Insulae. Che funzione esercita il “buio” nel tuo linguaggio e con esso la contrastante presenza della luce artificiale?
Ti rispondo con il testo che accompagna le mie riflessioni sulla notte. “Fotografare, disegnare con la luce. Di notte, specie in quelle senza luna, la lavagna è nera. E i pastelli, i gessetti, hanno il colore delle luci artificiali. Lampade a solfuri verdognole, lampade al neon, fari a luce bianca quasi alogeni. Il misto delle luci genera bagliori assoluti, assordanti per contrasto in un silenzio che è riposo di uomini, animali e cose. Le sensazioni, a rivedere in foto i risultati, prima di quelle dell’osservatore, sono le mie. Quelle del fotografo. La presenza rassicurante dell’auto accanto. Un cane in lontananza, un camion che decelera e che con i suoi fari illumina la scena. La scena. Un incontro folgorante tra la propria idea interiore, il senso del racconto del progetto in corso, la sua collocazione in una sequenza mentale di immagini che narrino in modo poco esplicito, e che piuttosto suggeriscano una chiave di lettura. Che infonda mistero e indefinito, che dialoghi ai confini del visibile, con una intelligibilità del soggetto e che ispiri chi guarda a trovare la propria lettura, a farsi trasportare dall’immagine in un mondo parallelo, immersivo, con occhi simili a quelli miei. Nella campagna che lo circonda al confine tra la terra e il cielo mentre tutti dormono e io, ostinato, rimango a guardare.”
SPECTRUM: In Touch Ground ti occupi dell’attualissimo problema dei fenomeni migratori nel Mediterraneo, ma lo fai senza mai mostrare un migrante. Oggetto della tua ricerca sono i luoghi di sbarco e i relitti delle imbarcazioni che hanno condotto quest’umanità da una sponda all’altra del mare. Ritieni che questi “segni” siano sufficienti a raccontare il drammatico fenomeno?
Non penso siano segni sufficienti. Sono altri “segni”. Touch Ground è una riflessione sui luoghi in cui sono avvenuti sbarchi, anche, a volte, tragici. ?à una riflessione tra il confine tra terra e mare dal nostro punto di vista: il nostro mare, le nostre spiagge, possono essere, visti al contrario, agognate mete da raggiungere. Per questo mi interessava raccontare questo mare di notte, perché spesso gli sbarchi sono avvenuti di notte e perché, nel fotografare relitti spiaggiati o silenziose linee di costa ho provato una grande suggestione personale. Che non so se è arrivata nelle fotografie e forse neanche mi interessa saperlo: in fondo, il primo “gustatore” delle proprie immagini è, a mio avviso, proprio il creatore delle stesse.
SPECTRUM: Simulacra è uno dei tuoi progetti di maggior successo. In esso riprendi in immagini il famoso concetto di Baudrillard calandolo nella realtà dell’Italia meridionale e indagando forme architettoniche devozionali che appartengono alla nostra cultura, ma a cui nessuno sembra fare più caso. Esiste ancora uno spazio per il simulacro nella nostra cultura, oppure l’unico vero simulacro è rimasta la fotografia?
Credo ci siano ancora tanti simulacri. E non so se la fotografia, per come è consumata oggi come oggetto primariamente da condividere e dimenticare, è ancora un simulacro. Recentemente mi sono imbattuto in alcuni “simulacri” in Cina: culture diversissime eppure simili agli altari votivi. In fondo è la funzione di questi artefatti che è mutata nel tempo: marcano ancora crocevia e riferimenti visivi ma nell’epoca dei GPS non servono più neanche all’orientamento sulle strade, figurarsi a quello spirituale.
SPECTRUM: In Insulae proponi una lettura del territorio attraverso una serie d’insediamenti industriali che, grazie al complice intervento della notte, appaiono come delle vere e proprie presenze “aliene” in un paesaggio che da esse, grazie alla potenza della luce, viene dominato. Qual è la forza di questo lavoro che tanto successo ha riscosso all’estero, al punto da essere acquistato dalla George Eastman House di Rochester?
Non sono solo strutture industriali ma anche luoghi in cui le forze USA di stanza in Sicilia risiedono. Tra di loro anche il CARA di Mineo che prima era uno dei residence US in Sicilia. Un articolo sul New York Times su Insulae ha aperto la strada al successo del lavoro: da l?¨ una mostra negli States in cui il direttore della Eastman House è venuto e ha apprezzato il lavoro. In Insulae, ancora, fotografo confini e recinzioni. La storia del sonno dei soldati e delle loro famiglie si intreccia con i fili spinati, con la lotta tra il buio e la luce, metafora sempreverde del dualismo che tanto ha impregnato la nostra cultura. Positivo e negativo, bene e male, zero e uno. E il bagliore distante diventa un UFO appena atterrato o che sta per partire, un neon acceso, una barra di kriptonite.
SPECTRUM: Il paesaggio industriale è oggetto anche di Refinery Flocks, una serie in cui alla rigida verticalità delle ciminiere del polo petrolchimico di Gela viene opposta l’amorfa o multiforme presenza di stormi d’uccelli. Il tuo è stato un tentativo di umanizzazione di un luogo tanto controverso o gli uccelli sono una metafora hitchcockiana di una minaccia possibile?
Il fenomeno noto con il nome inglese di “murmuration” dal latino “murmuratio” è affascinante di suo. Altri fotografi hanno, con successo, dopo il mio Refinery Flocks, fotografato stormi di uccelli. Qui la cosa paradossale era il rapporto utilitaristico tra il calore della raffineria di Gela, oggi spenta, e gli uccelli al tramonto nelle notti d’inverno. Simbiosi possibile piuttosto che minaccia hitchcockiana.
SPECTRUM: A proposito di minacce possibili, tra i tuoi lavori documentari viene indagato anche il “problema” mai risolto del MUOS di Niscemi. Come hai affrontato l’indagine su un tema che ancora oggi fa tanto discutere?
Il progetto sul MUOS ha visto la collaborazione delle associazioni e delle scuole di Niscemi. Una coppia di straordinari amici che abitano nella sughereta mi ha fatto conoscere le problematiche del MUOS ed è stata un’esperienza molto intensa per me vedere la passione di queste persone per una causa tanto controversa. E poi, confini, nuovamente e muri e fili spinati. Il progetto avrebbe dovuto essere pubblicato sul New York Times ma alla fine la cosa non è andata in porto. Non è difficile immaginare il perché.
SPECTRUM: Sin dall’inizio della tua attività fotografica hai cercato, con successo, di proporre le tue immagini in contesti internazionali, ma i riferimenti alla “tua” Sicilia rimangono continui. Numerosi infatti sono i “saggi” fotografici a essa dedicati, compresi quelli sulle feste religiose, in cui, dopo tanti luoghi, ti confronti direttamente con gli esseri umani e con la loro “dimensione spirituale”. Ritieni che queste indagini siano complementari ai lavori sui luoghi o che entrambe seguano percorsi paralleli?
Sono indagini complementari. Certo, troppo sfruttati e “visti”. Difficili essere originali ed autoriali su queste tematiche. Ma se senti lo stimolo di fotografarle allora bisogna sempre seguirlo. Come però avrai visto questi lavori sono tra i miei “essays”, non tra i progetti principali. Non perché li ritengo di serie B, ma perché li trovo, appunto, complementari ai lavori principali.
SPECTRUM: Come già evidenziato, hai viaggiato tanto “dentro” la Sicilia, ma hai viaggiato tanto anche all’estero. New York, Parigi, Cuba, Dresda, la Florida, la Tunisia sono state oggetto del tuo sguardo. Ogni luogo è stato raccontato con un linguaggio apparentemente diverso. Come cambia il tuo modo di vedere in contesti differenti? E’ il luogo che suggerisce il modo in cui vuole essere ritratto o sei tu che ami reinventarti di volta in volta?
Gli “essays” sono volutamente liberi. Nel linguaggio e nella tematica. Sono meno rigoroso e più sperimentatore nell’approccio. E ogni luogo ha le sue vibrazioni caratteristiche. Quando arrivo in un posto nuovo entro in crisi e mi domando: e ora come dovrei fotografare qui per cogliere questo posto?
SPECTRUM: Nella serie The Other America, il cui titolo a primo impatto sembra richiamare un lavoro di Sebastiao Salgado sul Sud America, mostri, con un rigoroso bianconero (per anni ho creduto fotografassi solo a colori), luoghi insoliti nel paesaggio statunitense, in cui è l’abbandono a farla da padrone. Trovi che questo “degrado” sia visivamente poetico? E che ruolo gioca la dimensione del “tempo” in queste tue fotografie?
The Other America è una serie del 2007 importante per me. Corrisponde a una di quelle “crisi” nell’interpretazione del luogo a cui facevo riferimento prima. E, contemporaneamente, a un concetto “suspended” che stavo sperimentando in Sicilia da un po’ di tempo. Non lo definirei però “degrado”. Mi sono sempre sembrate cose che, tutto sommato, valeva la pena restassero come erano. Quietate. Inutili da spostare o da rimuovere. Un’altra America che lascia stare e non demolisce.
SPECTRUM: Lo stesso abbandono lo ritrovi e lo ripercorri nella serie Sicily Houses. Questa connessione è sufficiente per mettere in relazione luoghi cos?¨ lontani e cos?¨ diversi?
Anche le case della Sicilia sono un embrione di Suspended. Più didascalico, fu oggetto di una prima mostra a Catania mi sembra nel 2007. La relazione tra i posti lontani esiste solo nel fatto che la stessa persona abbia realizzato queste immagini.
SPECTRUM: Percorrendo i tuoi lavori fotografici siamo rientrati in Sicilia dove, nuovamente con un appassionante bianconero, hai realizzato la serie Oculus Asini. I protagonisti di queste tue fotografie sembrano dialogare, attraverso i loro occhi, con te. Come nasce questa delicata sequenza fotografica?
Oculus è una serie nata per caso che ha avuto un buon successo in Francia. In visita a un allevamento rimasi colpito dalla profondità dell’occhio dell’asino, dalla sua dolcezza e pazienza. E anche, ancora, dal confine del filo spinato o delle stalle. Come vedi alla fine molto gira sempre intorno alla stessa metafora.
SPECTRUM: Osservando le tue opere, ho trovato una serie che mi ha lasciato a dir poco interdetto. Mi riferisco a Sichuan, lavoro in cui metti in scena un paesaggio distrutto, ossimoricamente creato con i mattoncini delle famose “costruzioni” per bambini. Il tutto appare come la “ricostruzione” di uno scenario post-bellico o post-terremoto, in cui il tuo continuo confronto con la realtà sembra essere stato sostituito da una dimensione dichiaratamente simbolica. Questa serie rappresenta un’anomala e giocosa sperimentazione nel tuo percorso autoriale o si colloca perfettamente in esso?
Lo scenario post devastazione era quello che sivedeva in TV dopo il terremoto avvenuto in Cina nel 2008, che aveva causato circa 70.000 morti. L’idea è stata quella di riprodurlo con i Lego. Segni “finti” di un qualcosa realmente accaduto. Forse questo, a ripensarci, il trait d’union con Touch Ground. Sicuramente una sperimentazione visto che è l’unico progetto “staged” che ho mai realizzato.
SPECTRUM: Il tuo “agire” fotografico è sempre stato frutto di profonde riflessioni sul ruolo dell’immagine fotografica e del fotografo nella nostra società. Tale consapevolezza ha fatto di te uno degli autori più interessanti del panorama non solo italiano. Cosa dobbiamo aspettarci da Massimo Cristaldi nei prossimi anni? A quali progetti stai lavorando?
Sto lavorando a un paio di libri. Sono sempre andato per mostre e per progetti ma il libro è una sfida avvincente che adesso sento di essere quasi pronto ad affrontare. Non è semplice però e, certamente, metterà una data di fine ad alcuni dei progetti oggi “ongoing”. E poi sto lavorando su progetti più ampi che non siano collegati a un singolo posto o a un singolo genere fotografico. Sto fotografando di più le persone nei luoghi. Certamente sto mutando e maturando e lo vedo nelle fotografie che oggi realizzo. Questo mettere a fuoco se stessi è un processo interessante ma anche, a volte, spiazzante per sè e per chi vede i tuoi lavori, soprattutto in un mondo come quello della fotografia contemporanea in cui sembra che la “coerenza a tutti i costi” sia il valore principale da perseguire. Ma tanto io sono un confidente ottimista incoerente.