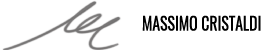Although In the popular imagination ruins are most commonly associated with archaeology, in an historical and Cultural perspective the theme of ruins covers a multiplicity of fields: literature, philosophy, the landscape, painting, the theory of conservation, architecture, urbanism, psychoanalysis, sociology and more. The exhibition is inspired by antiquity but does not intend Simply to present landscapes with ruins, nor to use an archaeological museum as a mere container for modern works in an a critical juxtaposition. The premise is that antiquity should never be self-referential, as If it held undeniable value, nor an empty Screen onto which to protect the Images and concepts of modernity. Rather, we believe that the remains of the ancient world can be valued if they lead us tp reflect on the present. As such the visitor to this exhibition should not come into immediate contact with what we might describe as ‘passive ruins’ the historicized and conventional evidence of a more or less distant past. Among other things ruins are often not entirely passive, but pose constant problems.
The initial contact should be with the ruins of the modern world, with disconcerting ruins. The idea to start from a contemporary event that has created ruins (the earthquake In L’Aquila?) and then continue with about ten sections organized by theme rather then date. Each section will host different materials and offers a diachronic vision of the theme tackled, sometimes starting from artifacts already in the museum. The idea is that the visitor should immediately grasp the subject, comparing with a recent experience, and then reflect on it from an historical point of view.
Marcello Barbanera e Alessandra Capodiferro
La nostra idea della mostra
Chi, di fronte a una mostra dal titolo La forza delle rovine, immaginasse di visitare la consueta esposizione di bucolici paesaggi pittorici disseminati di colonne spezzate e architetture classiche avvolte da rampicanti, rimarrebbe deluso. Sebbene una sezione sia dedicata ai paesaggi con rovine antiche nella pittura a partire dal XVI secolo fino al XX, questo tema non è stato mai centrale nella concezione della mostra, almeno per due motivi: il primo è che pur degno di interesse, il soggetto è altresì di scarsa originalità; l’altro è insito nella stessa idea generatrice di trattare le rovine come un fenomeno culturale più esteso possibile, che sollecitasse il visitatore al pensiero piuttosto che blandirlo con una anòdina esposizione di opere d’arte.
La scelta del tema non è stata determinata da un ordinario interesse dei curatori, che con le rovine – in termini pratici e concettuali – hanno a che fare usualmente. Fin dall’inizio il progetto è stato concepito con la consapevolezza e la determinazione di tenere due punti fermi: esplorare il soggetto nei suoi significati più ampi e in stretto riferimento al luogo dell’esposizione, il Museo di Palazzo Altemps.
Lo spazio migliore per allestire una mostra è quello vuoto, un involucro plasmabile in cui raccontare una storia per immagini. Gli spazi dei musei sono decisamente più difficili, perché hanno già una loro configurazione: il rischio più comune è quello della confusione tra opere esposte e oggetti della mostra temporanea, con le prime a fare da sfondo inerte a queste ultime. Palazzo Altemps ha una densità spaziale e di contenuto come sontuosa residenza patrizia e come raffinato involucro di una delle più importanti collezioni di scultura antica. Da questo assunto siamo partiti per costruire una mostra che, per la prima volta, attraversa tutte le sale museali e si struttura sulle loro priorità come un ospite dalla conversazione brillante ma che non dà sulla voce. Nel dialogo tra antico e contemporaneo le sculture di Palazzo Altemps costituiscono parte integrante del percorso allo stesso modo delle opere moderne e contemporanee in mostra. Provenienti da collezioni pubbliche e private, dipinti, sculture moderne, fotografie, acquerelli, incisioni sono stati scelti con il fine di costruire un discorso il più ampio possibile attorno alle opere della collezione permanente.
Definire l’oggetto della mostra è quasi impossibile, dato il suo aspetto proteiforme. Walter Benjamin infatti vedeva nelle rovine l’allegoria del pensiero stesso: «Le allegorie sono nel campo del pensiero, ciò che le rovine sono in quello delle cose». Caratteristica delle rovine è l’ambivalenza: sono sentinelle al confine del tempo, il quale ci sfugge a causa della sua fluidità e rapidità: da un lato stanno di fronte al tempo che le ha investite e modellate, riducendole a muro crollato, fantasmi di un edificio un tempo integro; dall’altro lato, proprio questa resistenza caparbia al trascorrere inesorabile del tempo, testimoniata dalla presenza fisica della costruzione, conferisce alle rovine senso della durata e diviene un’ancora per la memoria. Pertanto l’intenzione è stata fin dall’inizio porre il visitatore non in una condizione contemplativa ma di esortazione alla riflessione, facendo nostra la considerazione di molti artisti del dopoguerra, soprattutto tedeschi come Joseph Beuys o Anselm Kiefer che sulle rovine hanno fondato molta della loro poetica: «Sono nato tra le rovine» ha dichiarato Kiefer, «Io amo le rovine perché sono il punto di partenza per qualcosa di nuovo». Le sue opere contengono spesso libri, realizzati in piombo, un materiale fluido che si trasforma: nel processo alchemico il piombo doveva essere trasformato in oro, perciò anche i libri, spesso distrutti dalla furia irrazionale degli uomini, continuano la loro funzione, possono essere trasformati in un nuovo prezioso materiale per gli esseri umani: sotto le ceneri le braci della memoria si trasformeranno. Questa relazione stretta tra rovina e memoria l’aveva ben intuita Lévi-Strauss: «Trascinando i miei ricordi nel suo fluire, il tempo, più che logorarli e seppellirli, ha costruito coi loro frammenti le solide fondamenta che procurano al mio procedere un equilibrio più stabile e contorni più chiari alla mia vista…Fra questi due pilastri che segnano la distanza fra il mio sguardo e il suo oggetto, gli anni che li corrodono hanno cominciato ad ammassare i frammenti. Gli spigoli si assottigliano, intere fiancate crollano; i tempi e i luoghi si urtano, si sovrappongono o si capovolgono, come sedimenti smossi dal tremito di una scorza decrepita».
Sulla base di queste premesse è evidente che tutto il percorso della mostra è una continua meditazione sull’ambivalenza, sull’incompletezza, sulla frammentarietà dell’esistenza, sull’esigenza di conservare la memoria, sul frammento che suggerisce il ‘non più’ e il ‘ma ancora’, sulle schegge del passato che riemergono come pezzi dell’inconscio cui bisogna dare una collocazione, sull’insensatezza della guerra, sui monumenti alla libertà di ieri che smascherano gli oppressi di un tempo nel loro nuovo ruolo di oppressori, perché non c’è nessuna logica nella storia. Proprio per dare questo senso di attualità delle rovine la mostra apre sulla modernità, dal XX secolo in cui due guerre hanno causato distruzioni apocalittiche e resa necessaria e inevitabile la ricostruzione. Chi ha vissuto gli orrori della guerra non pensa che alla ricostruzione. Lo si può capire dalla testimonianza di Marc Augé: «Alla fine della seconda guerra mondiale non si parlava che di ricostruzione…Mi piacevano moltissimo le città nuove che sembravano spuntare dal suolo…I miei gusti sono cambiati…Ma a quell’epoca la ricostruzione era, insieme alla musica e ai film americani, il simbolo di una vita pulita, moderna e brillante a cui aspiravo». Così la prima sezione della mostra (Catastrofi: rovine moderne e contemporanee) si apre sulle catastrofi, naturali e artificiali: guerre, disastri nucleari, terremoti, attentati. Scenari di rovine presentati – oltre che in pittura e in fotografia – attraverso il medium cinematografico, dalla Germania postbellica all’11 settembre 2001. La sezione seguente (Torso: dal desiderio di integrità al culto del frammento) ruota intorno al frammento di statua colossale, il cd. Polifemo della collezione Altemps, e alle sculture di divinità restaurate e integrate nel Sei- e Settecento. Un calco del XVIII secolo del Torso di Belvedere evoca il tema della scultura antica e della sua influenza sugli artisti, da Michelangelo ai contemporanei. Fino all’inizio dell’Ottocento, le sculture antiche, rinvenute frammentarie, venivano completate da scultori celebri come Alessandro Algardi e Lorenzo Bernini prima di giungere nelle raccolte delle famiglie patrizie a Roma, Firenze e nei principali paesi europei. A Roma vi erano botteghe specializzate di restauratori-scultori come Bartolomeo Cavaceppi e Vincenzo Pacetti che alimentavano un commercio artistico fiorente, talvolta prossimo alla truffa. L’estetica dell’Ottocento si avviò comunque – non senza polemiche – verso l’accettazione dell’estetica del frammento: Rodin ne fu l’eroe.
La terza sezione (Paesaggi di rovine) è dedicata alle rovine che diventano una costante del paesaggio pittorico dal XVI secolo in poi: Roma divenne il luogo dove gli artisti si recavano per un soggiorno indispensabile nella loro formazione. D’ora in poi il tema delle rovine nella pittura si articolerà praticamente senza soluzione di continuità fino all’arte contemporanea con timbri e registri multiformi. Da una dimensione onirica a un brusco risveglio segue la sezione Rovine del paesaggio. L’occhio dei fotografi mette a nudo paesaggi violentati, sfruttati, dove in breve tempo gli uomini hanno accumulato relitti industriali e umani che non possono aspirare allo status di rovine, perché la “storia futura” di cui parla Marc Augé è già qui: «La storia futura non produrrà più rovine, non ne ha il tempo».
In una mostra sulle rovine non poteva mancare un settore dedicato a Giambattista Piranesi (Anatomia delle rovine). Piranesi è il cantore di un passato eroico, sulle cui membra architettoniche posa il proprio sguardo scrutatore: «I suoi muri non sono soltanto una superficie» – ha scritto Henri Focillon – «ma un volume. Bisogna approfittare di questi lembi sventrati e di questi crolli per penetrare i segreti della loro struttura; se necessario, bisogna fare sondaggi e scavi».
A questo punto del percorso, il linguaggio visivo viene interrotto per l’inserimento di uno dei linguaggi più potenti dell’espressione artistica, quello musicale (Frammento, memoria, creazione: il cammino della musica). Qui il frammento costituisce l’idea di partenza così potente da generare sviluppi. La Marcia funebre dell’ Eroica di Ludwig van Beethoven fu costruita attorno a un frammento di poche note e in anni recenti il Rendering (1990) di Luciano Berio è concepito come omaggio/traduzione/restituzione a Franz Schubert.
Dopo il suono Il canto delle rovine. Basterebbe solo citare l’Archaïscher Torso Apollos (1908) di Rainer Maria Rilke o La terra desolata, il poemetto con il quale Thomas Stearns Eliot inaugurò il Modernismo in poesia nel 1922 per parlare di frammenti e rovine nella poesia. Naturalmente si può risalire molto oltre, al Cicerone delle Tuscolane (III, 53), dove il celebre oratore esprime la commozione che aveva provato nel vedere le rovine di Corinto. Dal soffitto della sala grande del Galata scendono fogli come in volo: rimandano ai Mu‘allaq?t, i Poemi sospesi dell’era preislamica tradizionalmente scritti in lettere dorate su pezzi di lino ripiegati e appesi (allaqat) sulle tende che coprivano la Ka’ba.
Smentendo quanto pensava Diderot «Beati gli antichi che non avevano un’antichità» la sezione seguente (L’errore di Diderot: le rovine nell’antichità classica e orientale) propone il confronto con la percezione delle rovine nel mondo antico. Nella Grecia antica il discorso sulle rovine si riallaccia alla formazione dei culti eroici, sorti intorno alle presenze monumentali della tarda Età del Bronzo, percepite nell’età omerica come appartenenti a un mondo mitico, a una dimensione eroica. Per i Romani le rovine sono immagine materiale del destino, un’assenza senza possibilità di redenzione, sempre assimilata a paesaggi desertici, evocanti morte. Anche le civiltà orientali antiche hanno conosciuto un culto delle rovine che non aveva niente da invidiare all’Occidente, ma hanno utilizzato altre strategie e intrapreso percorsi differenti rispetto al mondo classico.
La mostra si conclude con una sezione il cui tema entra nel vivo di un dibattito sempre attuale, soprattutto a Roma, quello della relazione tra archeologia e modernità. Dall’Ottocento, alle rovine storicizzate si aggiungono quelle portate alla luce dai nuovi scavi. Talvolta esse si trovano in luoghi disabitati, dove non c’è stata continuità di vita: sono le più facili da indagare, studiare e integrare o (ri)costruire. Spesso però si trovano sotto gli strati delle città moderne o convivono con esse in superficie. L’archeologia si occupa di presenze e assenze, perciò – come Freud aveva intuito – ha a che fare con uno status che non è né vita né morte. I morti divengono oggetto del desiderio, sepolti e irraggiungibili, eppure richiamabili alla vita attraverso un atto d’amore: il ricordo. L’archeologia si occupa di città di morti che affiancano città di vivi e non sempre la loro relazione è facile da comprendere. «Suppongo che ci deve essere una storia importante dietro tutto questo» è l’innocente commento di una signora americana al cospetto dei fori in un cartoon di Alan Dunn del 1953.